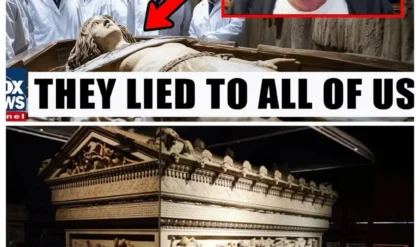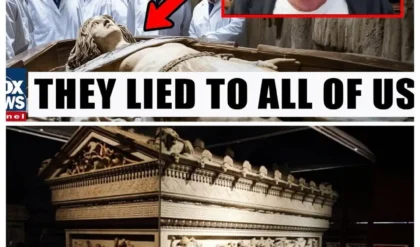Un’onda d’urto. Un terremoto che ha scosso le fondamenta del dibattito pubblico italiano, riaccendendo una discussione cruciale e, per molti, pericolosa. Al centro di questa tempesta, le parole taglienti, affilate come lame, di uno degli intellettuali più in vista del Paese. Non si è trattato di un’analisi politica come tante, ma di una vera e propria dichiarazione di guerra culturale, pronunciata in uno dei salotti televisivi più seguiti, che ha costretto milioni di italiani a riflettere sullo stato reale delle nostre istituzioni.
La scena è quella di “8 e mezzo” su La7, un palcoscenico privilegiato condotto con la consueta maestria da Lilli Gruber. Ma quella sera, il confronto ha superato ogni aspettativa. Il protagonista indiscusso è stato Massimo Cacciari. La sua presenza è sempre garanzia di analisi profonde, spesso scomode, ma questa volta le sue affermazioni hanno travalicato il semplice commento. Hanno assunto i contorni di una denuncia pubblica di rara veemenza, squarciando quello che il filosofo ha implicitamente definito un velo di ipocrisia e omissione.
L’attacco di Cacciari non è stato generico. Non ha puntato il dito contro la “politica” nel suo insieme. No, ha mirato dritto al vertice. Al Colle. Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
È raro, nel nostro Paese, assistere a una critica così diretta e incisiva nei confronti del Capo dello Stato, la figura che per definizione incarna l’unità nazionale. Ma Cacciari non si è trattenuto. Con una lucidità spietata, ha sollevato interrogativi che molti, forse, pensano in privato ma che nessuno osa pronunciare in pubblico.
I punti focali della sua denuncia sono stati chiari. Ha parlato di una “condiscendenza inaccettabile” da parte del Quirinale nella gestione delle recenti crisi istituzionali. Secondo il filosofo, di fronte a decisioni che avrebbero richiesto fermezza, il Colle avrebbe mostrato una flessibilità che, a suo dire, mina la credibilità stessa delle istituzioni e, di conseguenza, la fiducia dei cittadini nel sistema.
Non solo. Cacciari ha rincarato la dose, parlando di un “silenzio complice” e di una “omissione” che permetterebbe a determinate pratiche di perpetuarsi indisturbate. Nella sua analisi, questo silenzio non è una semplice mancanza, un’assenza. È un’attiva complicità, un fattore che erode lentamente ma inesorabilmente le basi stesse della nostra democrazia.
E poi, la domanda che è risuonata come un tuono nello studio e nelle case degli italiani: “Dov’è il garante della Costituzione?”. Cacciari ha chiesto pubblicamente conto a Sergio Mattarella, sostenendo con forza che il Presidente, pur essendo il supremo garante della Carta, permetterebbe “che i principi fondamentali dello Stato vengano violati quotidianamente”. Un’affermazione di una gravità inaudita, che solleva un quesito fondamentale: chi vigila sul rispetto della Costituzione, se il suo garante è messo in discussione in modo così aperto?

L’analisi di Cacciari, però, è andata ben oltre la persona del Presidente. Si è trasformata in un atto d’accusa contro un intero sistema che, secondo il filosofo, ha “smarrito la bussola”, tradendo la fiducia dei cittadini. Un sistema, ha spiegato, dove la forma ormai prevale nettamente sulla sostanza, e dove le voci critiche, quelle fuori dal coro, vengono sistematicamente messe a tacere o ridicolizzate.
Ha denunciato la creazione di “emergenze costruite a tavolino”, utilizzate come strumenti per giustificare misure discutibili e, di fatto, limitare le libertà individuali e collettive. Un meccanismo pericoloso, ha avvertito, che serve a consolidare il potere di pochi a scapito dei diritti di tutti.
Nel suo j’accuse è finito anche il Parlamento, descritto come “esautorato”, spogliato del suo potere e ridotto a un mero organo di ratifica. Un “passacarte” di decisioni prese altrove. Questa debolezza della rappresentanza democratica, ha sottolineato Cacciari, svuota di significato il voto dei cittadini e allontana la politica dalla vita reale delle persone. Un parlamento debole è, per definizione, una democrazia debole.
Infine, l’affondo sui media, accusati di essere “piegati al potere”, di evitare le domande scomode, compromettendo così la loro funzione essenziale di “cani da guardia” e di informazione. Un vulnus grave, perché una cittadinanza non informata è una cittadinanza che non può partecipare consapevolmente.
La tensione nello studio di “8 e mezzo” era palpabile. I tentativi, peraltro professionali, di Lilli Gruber di arginare la piena del filosofo si sono rivelati vani, quasi impotenti di fronte alla forza delle sue argomentazioni. Cacciari non era lì per un dibattito. Era lì per lanciare un messaggio, senza filtri né compromessi.
Il momento culminante, quello che è già diventato un simbolo, è arrivato quando Cacciari ha pronunciato la frase: “Spegnatemi il microfono!”. Un’affermazione che ha lasciato tutti attoniti. Non è stato un capriccio, non una provocazione fine a se stessa. È stato interpretato da molti come il culmine della sua denuncia. Un grido di protesta estremo contro quel “silenzio complice” che, a suo dire, soffoca il dibattito reale nel Paese.
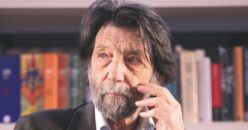
“Spegnatemi il microfono” è diventato, in pochi istanti, il simbolo della frustrazione di milioni di cittadini che si sentono inascoltati, che vedono le loro preoccupazioni ignorate da un sistema che sembra non voler sentire le voci fuori dal coro. Un gesto che ha travalicato il contesto televisivo per diventare un’icona di resistenza intellettuale.
L’episodio, come prevedibile, ha generato un’onda d’urto immediata sui social media, con un dibattito infuocato. Ma, come sottolineato da molti osservatori, la reazione dei principali quotidiani italiani è stata, per usare un eufemismo, “imbarazzata”. Si è tentato di minimizzare l’evento, di ridurlo a una “provocazione”, a un “eccesso di retorica” del filosofo. Una reazione che, involontariamente, sembra quasi confermare una delle tesi di Cacciari: quella di un sistema mediatico che fatica a gestire il dissenso radicale, specialmente quando tocca i vertici dello Stato.
L’intervento di Cacciari non è stato solo un momento di televisione. È stato un campanello d’allarme. Ci piaccia o no, ha dimostrato come la parola, anche se scomoda e controcorrente, possa ancora scuotere le coscienze e mettere in discussione lo status quo. È un monito potente sul valore del pensiero critico in una società che tende sempre più all’omologazione. Ci ha ricordato l’importanza di figure che non temono di sfidare il potere e di porre domande difficili, anche quando la risposta è difficile da ascoltare.